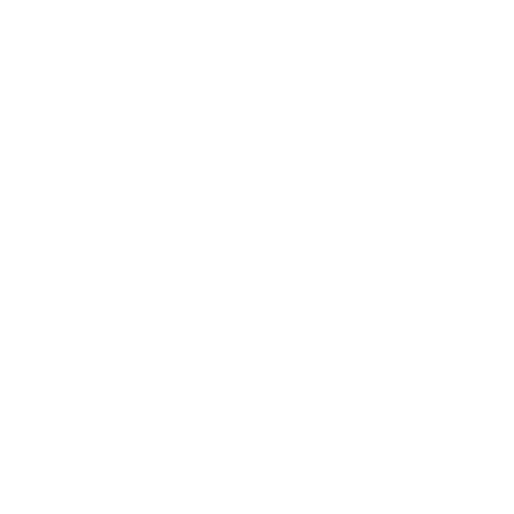Francesca Cavallini, psicologa, dottore di ricerca, fondatrice di Tice e donna neurodivergente racconta in questo blog come la psicologia e le scienze sociali abbiano cambiato il modo di considerare le persone neurodivergenti e fornirà alcuni spunti importanti nella relazione con persone neurodiverse.
If you have any questions you can write to francesca.cavallini@centrotice.it
Racconto spesso questa storia, perché è un po’ l’origine della mia idea di talento e della mia vita professionale.
Era il 1988. Vivevo in un piccolo villaggio della Val Tidone, in provincia di Piacenza. Mia madre lavorava come insegnante di sostegno in un istituto professionale che, per dirla tutta, si sarebbe potuto definire — senza troppi giri di parole — “una scuola superiore per ragazzi senza talento per lo studio”. Una struttura allora moderna, grigia, con mattoni rossi a vista e cornicette geometriche intorno a porte e finestre.
Lì finivano studenti ripetenti, spesso più volte bocciati alle medie, i primi giovani con origini migratorie e poca dimestichezza con l’italiano, ragazzi e ragazze con difficoltà emotive e comportamentali. Era un miscuglio di apatia, impulsività, svogliatezza, disagio.
Avevo dieci anni allora e mi si poteva definire una bambina “talentuosa”: andavo bene a scuola, leggevo molto, ero brava negli sport e sapevo parlare in pubblico. Non senza un po’ di imbarazzo, ammetto che avevo anche una certa inclinazione naturale per la cura dei più piccoli: adoravo stare con i bambini, e loro si divertivano con me. In famiglia tutti sognavano per me un futuro brillante, fatto di passioni, impegno e successi.
Quando mia madre non sapeva dove lasciarmi, mi portava con sé all’istituto. Io odiavo quel posto. Mi dava fastidio stare in mezzo a quegli adolescenti arrabbiati, svogliati, che sembravano non avere altri interessi se non chiacchierare, fumare, dire parolacce. Mia madre, invece, si dedicava con pazienza alle lezioni di recupero individuale con chi aveva più difficoltà.
Le sue lezioni si svolgevano in un’aula lunga e stretta, le pareti un tempo bianche ormai grigiastre, con l’odore tipico dei luoghi troppo vissuti, tra sudore adolescenziale e un silenzio denso di vuoto. Le pareti erano segnate da strisce più scure: residui di scotch che un tempo reggevano cartelloni. Pochi banchi, una cattedra, armadietti metallici.
Per rendere l’ambiente meno freddo, mia madre aveva creato una sorta di angolo intimo: delimitato dalla cattedra spostata e dagli armadietti, al centro due sedie malconce, con parolacce incise e gomme da masticare appiccicate sotto. Era lì che si sedeva, aspettando che i ragazzi arrivassero, con il loro passo svogliato, la voce gracchiante, il corpo impregnato di odori.
A volte mi chiedeva di sedermi accanto a lei, di partecipare alle conversazioni. Ma io preferivo nascondermi. Mi rifugiavo nell’armadietto alle sue spalle, uno di quelli grandi dove si appendono i giubbotti, rannicchiata con una pila in mano a leggere e, senza volerlo, ad ascoltare.
Mia madre iniziava sempre chiedendo:
“Dimmi, in cosa sei bravo?”
Spesso la risposta era un muto “non lo so”, o un vago “boh”, oppure “a niente”. E lei, senza forzare, aspettava. Restava lì, in silenzio. Quel tipo di silenzio che non giudica, non spinge, non pretende. Gli studenti, abituati a essere interrogati, valutati, puniti, rimanevano spiazzati da quell’assenza di aspettative. Ed era proprio in quel vuoto che, pian piano, cominciavano a parlare. Prima timidamente, borbottando, poi trasformando quei suoni incerti in parole e racconti.
Per me, ascoltare quella parte dell’incontro era una magia. In quelle voci titubanti, incerte, nascoste dietro balbettii, prendeva forma il talento che nessuno aveva mai chiesto loro di raccontare.
Alcuni dicevano di saper giocare a calcio, altri di saper tagliare i capelli o cucinare. Alcuni ci mettevano tempo, altri lo sapevano subito. In quel momento, sembravano cambiare: da adolescenti svogliati e rabbiosi diventavano, per un attimo, esseri umani appassionati.
Poi si tornava alle materie scolastiche, e quella luce si spegneva un po’, fino all’arrivo del prossimo ragazzo, della prossima storia.
Una volta entrò un ragazzo, Sacha, credo si chiamasse così. Quindici anni circa, alto, qualche pelo biondo a spuntargli sul mento tra le efelidi. Era arrabbiato, appena finito lì dopo aver insultato un professore. Goffo, nervoso, infastidito.
Mia madre, con tono quasi distratto, gli chiese:
“E tu? In cosa sei bravo?”
Silenzio.
Un silenzio diverso dagli altri. Più duro, più ostile.
Dall’armadietto, smisi di leggere. Quel silenzio aveva un suono tutto suo. E io pensai, con dispiacere:
“Forse lui davvero non è bravo in nulla.”
Mi faceva male pensarlo, speravo di sbagliarmi. Speravo che anche per lui arrivasse quel momento di orgoglio e sorriso, il momento della scoperta.
Il silenzio si fece lungo. Dieci minuti, forse di più. Io speravo che mia madre rompesse quell’attesa, che gli desse una mano, gli suggerisse qualcosa. Ma niente. Lei restava lì, senza domande, senza pressioni.
Io, chiusa nell’armadietto, sentivo crescere l’impazienza, la voglia di uscire e gridare:
“Ma ci sarà pure qualcosa, anche una cosa piccola, che sai fare bene!”
Ripensandoci, mi vergogno un po’ di quella me di dieci anni. Ero già intrisa del pregiudizio che il talento si potesse trovare solo altrove, non in quella scuola. Pensavo che al massimo lì ci potesse essere qualcuno bravo nello sport. Ma mia madre no. Lei sapeva aspettare.
E quel silenzio, che avevo scambiato per sterile opposizione, si rivelò invece uno spazio di fiducia.
Silenzio.
Silenzio.
Silenzio.
Poi, finalmente, un suono, una voce:
“Quando non ho voglia di andare a scuola, vado a curare i canarini di mio nonno. Ne ha quindici. Ho imparato che se fanno certi versi hanno fame, se ne fanno altri hanno sete. Se canto io, loro mi rispondono… ho capito, più o meno, la loro lingua.”
Lo disse con una colata di imbarazzo, quasi ridendo di sé stesso, temendo di aver detto una sciocchezza.
Restò lì, fermo, stupito dalle proprie parole. Per un attimo, lo vidi ammirarsi. Per un attimo, luminoso e denso, si era sentito capace.
Mia madre gli sorrise e disse semplicemente:
“Che bello, Sacha. Grazie. Questo è un talento che non avevo mai sentito raccontare.”
Silenzio.
Silenzio.
E in quel silenzio, il profumo dolce e umile dell’orgoglio.
La mattinata si chiuse con Sacha che, ancora un po’ imbarazzato, raccontava dei canarini, di quanto si arrabbiava il nonno quando lui li faceva cantare tutti insieme.
Salita in macchina, sulla nostra Renault 4 rossa, chiesi a mia madre:
“Ma secondo te, Sacha ha davvero un talento?”
E lei, serena, rispose:
“Chi lo sa… il talento da solo non basta.”
Sono passati più di trent’anni da quella mattina con Sacha e mia mamma.
Io, da allora, sono cresciuta, ho smesso di nascondermi negli armadietti e ho passato molto tempo a studiare gli esseri umani e la loro mente. Ho analizzato il significato del talento, approfondito metodologie per supportare l’apprendimento, cercato di comprendere come si possa davvero aiutare qualcuno a esprimere il proprio potenziale.
Ma Sacha non l’ho mai dimenticato.
Ogni volta che racconto questa storia, quasi per gioco, digito su un motore di ricerca:
“traduttore di canarinese”.
E puntualmente scopro che non esiste. Nessuno lo ha inventato. Nemmeno Sacha.
E allora mi chiedo:
“Cosa mancava a Sacha per esprimere davvero quel talento, per renderlo visibile, concreto, possibile?”
La risposta, dopo tutti questi anni, mi appare più chiara:
Mancavi tu.
Mancavo io.
Mancavamo noi.
Ecco la mia conclusione, il senso profondo che quella storia continua a insegnarmi ancora oggi:
Il talento non riguarda solo me, o solo te, e tanto meno solo la tecnologia o l’intelligenza artificiale. Il talento esiste, si manifesta e si esprime solo dentro una dimensione di relazioni significative. È qualcosa che succede tra le persone, nello spazio del noi.
Noi.
Francesca Cavallini

Francesca Cavallini, psicologa, dottore di ricerca, fondatrice di Tice e donna neurodivergente racconta in questo blog come la psicologia e le scienze sociali abbiano cambiato il modo di considerare le persone neurodivergenti e fornirà alcuni spunti importanti nella relazione con persone neurodiverse.
If you have any questions you can write to francesca.cavallini@centrotice.it